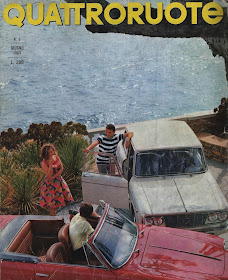Il paesaggio e la presenza umana a Cefalù in una fotografia che ricorda lo straordinario e passato scenario di una cittadina sospesa fra ricordi della storia e suggestioni delle leggende
Ancor oggi, a chi viene da Palermo, Cefalù non svela immediatamente l'inconfondibile profilo della sua rocca e della sua cortina di case affacciate sul mare.
Per ammirarne il secolare volto di città raggomitolata ai piedi della montagna è necessario scoprire la proliferazione della moderna edilizia delle "seconde case", attaccate l'una all'altra come in un'anonima città.
La fotografia riproposta da ReportageSicilia rimanda ad una Cefalù in cui gli uomini non ne avevano ancora compromesso l'antica ambientazione naturale ed lo straordinario aspetto urbanistico.
L'immagine svela un luogo in cui rocca, cielo, mare e centro abitato si integrano in un perfetto equilibrio di ruoli: uno spettacolo perduto per sempre e neppure immaginabile per le comitive di turisti che oggi invadono Cefalù e la sua spiaggia.
La trasfigurazione ebbe inizio agli inizi degli anni Sessanta, quando il comune rilasciò decine di licenze edilizie che portarono alla distruzione di vaste aree di macchia mediterranea e di una necropoli del IV secolo ( la cui esistenza è testimoniata da alcuni reperti conservati al Museo Madralisca ).
L'immagine del post, tratta dal volume "Sicilia" dell'Enciclopedia delle Regioni Meravigliosa Italia, Edizioni Aristea ( 1971 ), risale più o meno al periodo in cui il giornalista Corrado Sofia - nel 1962 - poteva ancora scrivere di Cefalù:
Ancor oggi, a chi viene da Palermo, Cefalù non svela immediatamente l'inconfondibile profilo della sua rocca e della sua cortina di case affacciate sul mare.
Per ammirarne il secolare volto di città raggomitolata ai piedi della montagna è necessario scoprire la proliferazione della moderna edilizia delle "seconde case", attaccate l'una all'altra come in un'anonima città.
La fotografia riproposta da ReportageSicilia rimanda ad una Cefalù in cui gli uomini non ne avevano ancora compromesso l'antica ambientazione naturale ed lo straordinario aspetto urbanistico.
L'immagine svela un luogo in cui rocca, cielo, mare e centro abitato si integrano in un perfetto equilibrio di ruoli: uno spettacolo perduto per sempre e neppure immaginabile per le comitive di turisti che oggi invadono Cefalù e la sua spiaggia.
La trasfigurazione ebbe inizio agli inizi degli anni Sessanta, quando il comune rilasciò decine di licenze edilizie che portarono alla distruzione di vaste aree di macchia mediterranea e di una necropoli del IV secolo ( la cui esistenza è testimoniata da alcuni reperti conservati al Museo Madralisca ).
L'immagine del post, tratta dal volume "Sicilia" dell'Enciclopedia delle Regioni Meravigliosa Italia, Edizioni Aristea ( 1971 ), risale più o meno al periodo in cui il giornalista Corrado Sofia - nel 1962 - poteva ancora scrivere di Cefalù:
"Fino a qualche anno addietro, prima che l'ondata di modernismo spazzasse via le vecchie tradizioni, si potevano sentire da queste parti, lungo il mare o nelle strade dell'interno, canzoni come questa:
'di 'na finestra s'affacciau la luna, e 'nta lu mienzu la stidda Diana, su' tanti li splenduri ca mi duna, lampu mi parsi di la tramontana.
C'è lu Gaitu, ca gran pena mi duna, voli arrinunzi a la fidi cristiana.
Nun vi pigghiati dubbiu patruna, l'amanti ca v'amau, v'assisti e v'ama'
dove la luna sta a significare donna.
Una donna bella come una stella, un'apparizione folgorante.
'Lampu mi parsi di la tramuntana'
Dice dunque la canzone:
'Si affacciò una donna bella come la stella Diana e mi avvertì che il Kaid, il capo degli Arabi, pretendeva che essa rinunziasse alla fede cristiana.
L'amante la conforta, non abbiate timori, mia signora.
Il vostro antico amore vi rimane fedele, vi assiste e vi ama'
Sembra a ReportageSicilia che questa fotografia di Cefalù - per la solarità del paesaggio e per l'arcaico lavoro sulla spiaggia di uomini e asini - sia evocativa della millenaria storia della cittadina, nel 1962 assai più percepibile rispetto ad presente stravolto dal cemento e dai pullmann delle migliaia di turisti giornalieri.
In quel periodo, ancora Corrado Sofia poteva così rievocare le vicende e le leggende cefaludesi:
"Nella piazza di Cefalù, dove sorge la cattedrale, un tempo esisteva una moschea.
Durante gli scavi effettuati agli inizi del secolo per la pavimentazione stradale, scavi che i viventi ricordano e di cui nel locale museo si conservano alcune stele funerarie, vennero trovati i resti di un cimitero arabo.
Si sa che i Musulmani, quelli almeno di una certa casta, venivano sepolti attorno alla moschea.
Il che, se da una parte sminuisce o mette in dubbio la leggenda della tempesta e dell'ex voto di Ruggero II per la costruzione della cattedrale, dall'altra avvalora la regolare sostituzione che intorno all'anno Mille venne iniziata: chiese cristiane in luogo dei templi arabi.
Ruggero aveva scelto Cefalù per essere qui sepolto, il posto gli piaceva, il rumore del mare avrebbe cullato i suoi sonni eterni come in un poema dantesco; ma come in una tragedia di Shakespeare la sua tomba di porfido e quella dell'imperatrice Costanza conm uno stratagemma furono invece trasportate nella cattedrale di Palermo, dove tuttora riposano..."
dove la luna sta a significare donna.
Una donna bella come una stella, un'apparizione folgorante.
'Lampu mi parsi di la tramuntana'
Dice dunque la canzone:
'Si affacciò una donna bella come la stella Diana e mi avvertì che il Kaid, il capo degli Arabi, pretendeva che essa rinunziasse alla fede cristiana.
L'amante la conforta, non abbiate timori, mia signora.
Il vostro antico amore vi rimane fedele, vi assiste e vi ama'
Sembra a ReportageSicilia che questa fotografia di Cefalù - per la solarità del paesaggio e per l'arcaico lavoro sulla spiaggia di uomini e asini - sia evocativa della millenaria storia della cittadina, nel 1962 assai più percepibile rispetto ad presente stravolto dal cemento e dai pullmann delle migliaia di turisti giornalieri.
In quel periodo, ancora Corrado Sofia poteva così rievocare le vicende e le leggende cefaludesi:
"Nella piazza di Cefalù, dove sorge la cattedrale, un tempo esisteva una moschea.
Durante gli scavi effettuati agli inizi del secolo per la pavimentazione stradale, scavi che i viventi ricordano e di cui nel locale museo si conservano alcune stele funerarie, vennero trovati i resti di un cimitero arabo.
Si sa che i Musulmani, quelli almeno di una certa casta, venivano sepolti attorno alla moschea.
Il che, se da una parte sminuisce o mette in dubbio la leggenda della tempesta e dell'ex voto di Ruggero II per la costruzione della cattedrale, dall'altra avvalora la regolare sostituzione che intorno all'anno Mille venne iniziata: chiese cristiane in luogo dei templi arabi.
Ruggero aveva scelto Cefalù per essere qui sepolto, il posto gli piaceva, il rumore del mare avrebbe cullato i suoi sonni eterni come in un poema dantesco; ma come in una tragedia di Shakespeare la sua tomba di porfido e quella dell'imperatrice Costanza conm uno stratagemma furono invece trasportate nella cattedrale di Palermo, dove tuttora riposano..."