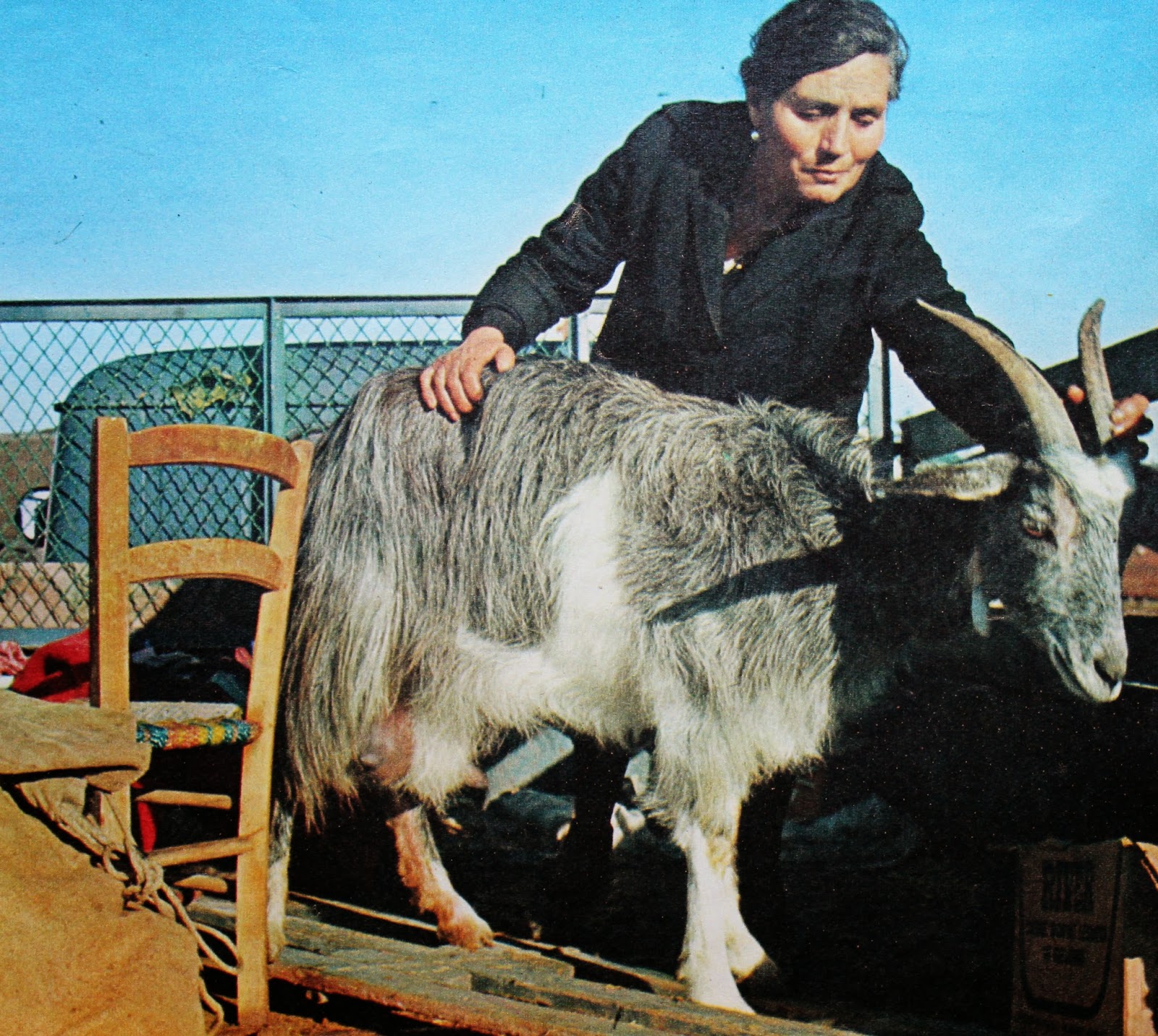Un racconto di Beppe Fazio pubblicato su "Civiltà delle Macchine" nel maggio del 1956 ricorda nomi ed aneddoti della prima edizione della gara, vecchia allora di cinquant'anni
Il 1956 coincise con il cinquantenario della Targa Florio.
L'anniversario venne celebrato dalla rivista "Civiltà delle Macchine" - edita a Roma da Finmeccanica - nel numero pubblicato per il bimestre maggio-giugno grazie ad un reportage del giornalista Beppe Fazio.
La narrazione di Fazio citò allora parecchi stralci dell'anonimo racconto della prima edizione della Targa Florio pubblicato all'epoca sul primo numero della rivista "Rapiditas", organo ufficiale di informazione della corsa madonìta dal 1906 sino al 1930.
La prima edizione della Targa prese il via all'alba della domenica del 6 maggio di 109 anni fa sul "Grande Circuito delle Madonie", con appena dieci vetture alla partenza: uno sciopero improvviso dei lavoratori marittimi rese impossibile lo sbarco in Sicilia di molti altri equipaggi.
Base logistica della manifestazione fu il Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese e, come è noto, il settore delle Tribune fu posto fra Campofelice e Bonfornello, a due passi dalle allora semisconosciute rovine del sito archeologico di Himera.
L'adesione del pubblico fu massiccia, in linea con quanto sarebbe accaduto nei decenni in cui la Targa Florio fu prova valida per il Campionato mondiale Marche: i primi due treni con 30 vagoni partirono da Palermo alle 3 ed alle 3.30 della notte, e fecero la spola a pieno carico dalla Stazione Centrale sino a Bonfornello per almeno tre ore.
Il racconto di Beppe Fazio - che "Civiltà delle Macchine" corredò con alcune fotografie delle vetture in gara e le note illustrazioni di Marcello Dudovich, Duilio Cambellotti e Aleardo Terzi - ricostruisce l'atmosfera di quella prima pioneristica Targa Florio, a metà strada fra evento sportivo ed appuntamento mondano.
Il dato agonistico della corsa passa in secondo piano rispetto al rilievo mostrato dall'accurata organizzazione della manifestazione da parte di un giovanissimo Vincenzo Florio.
L'inventore della Targa nel 1906 aveva appena 25 anni, ma dimostrava già quelle doti di intraprendenza e di organizzazione delle quali si è persa traccia da parecchi decenni in Sicilia.
Non è un caso che ancora ai nostri giorni l'unico evento siciliano conosciuto ancora fra molti appassionati sparsi nel mondo sia ancora, sempre ( e soltanto, purtroppo ) la Targa Florio.
"All'appello di Vincenzo Florio - scrisse Beppe Fazio - ben ventidue 'barriti crepitanti' risposero; anche se poi furono soltanto dieci le macchine che arrivarono in porto a Palermo, ospiti delle navi della flotta Florio, messe gratuitamente a disposizione ( un inopinato sciopero di portuali ne fermava dodici a Genova ).
Dieci macchine delle migliori case italiane e straniere, montate dai migliori assi del volante, ognuno col suo meccanico e, particolare gentile, accanto a un asso francese, una dama, Madame Le Blon, anche essa in veste di meccanico, anche le protegge il viso un femmineo bianco foulard di seta, che fa contrasto con la quadrata barba nera del marito.
Una nota gentile, che darà il 'la' alle targhe future, le quali saranno, non passerà un anno, le manifestazioni mondane preferite dalle signore; e si vedrà allora un comitato femminile d'onore composto dai più bei nomi dell'aristocrazia europea: la contessa d'Orsay, la principessa di Paternò, la Pignatelli, la principessa di Trabia, la Morosini, la marchesa di Soragna e infine, bella tra le belle, donna Franca Florio ( ai vecchi palermitani si incrina ancora la voce quando la nominano ).
Ma quest'anno ancora le signore sono un po' restie ad emergere, come divinità scese in terra dall'Olimpo, dalle nubi dorate, sollevate dalle macchine in corsa.
La Le Blon è un'altra cosa, è un esempio di dedizione coniugale, più che di spirito sportivo, e in corsa, seduta sulla poltroncina della sua Hotchkiss, avvolto ormai strettamente il viso nel foulard, come in un sudario, fa pensare, più che a un meccanico, alla moglie indiana che segue lo sposo oltre la vita.
Ma quel primo anno la corsa è un'avventura di audaci, è un salto nel buio e, pur se 'ciascun uomo moderno vive dieci vite', come scriveva l'entusiasta cronista del 1906, bisogna cercare di portarle a termine in certo qual modo tutte e dieci, e chi ci garantisce che quei 'titani sconosciuti' non saltino le stecconate?
Ma Vincenzo Florio, questo giovane gentleman di venticinque anni 'animato dalla più generosa e ardente passione per lo sport' ha pensato a tutto: con la sua capacità di divinazione ha capito che il circuito delle Madonie, diverrà col tempo una corsa ben più importante di quel primo tentativo di dieci vetture.
L'automobilismo sta diventando un fenomeno di massa, in quei primi anni del Novecento e il mondo industriale, in quel momento, guarda quel che succede nella lontana Sicilia; e anche quella 'lieta festa del progresso' non del tutto riuscita, è un nuovo passo verso l'ingresso definitivo dell'automobile nella vita sociale.
Bisogna stare molto attenti per evitare critiche e incidenti.
La eco delle 'frasi mordaci' contro le gare automobilistiche non era ancora spenta, circolavano ancora 'macchiette eccitanti all'odio che tendevano a far passare gli appassionati della nuova macchina divoratrice dello spazio come maniaci macabri'.
A queste bisognavano contrapporre una organizzazione di ferro.
Si pensi alla forza pubblica che si riuscì a concentrare sul posto.
Contro i dieci 'bolidi scatenati' si schieravano in pieno assetto di guerra 'duecento carabinieri, un gran numero di agebnti di polizia, tremila uomini di fanteria di linea schierati lungo il percorso, una compagnia di bersaglieri ciclisti incaricata del servizio di staffetta'.
L'ironia è facile, ma allora, grazie a quei brevi militari, 'il servizio d'ordine funzionò a meraviglia' e non si verificarono danni agli spettatori.
Del resto il pericolo di una guerra era ben lontano e i bersaglieri di Lamarmora nell'attesa, potevano tranquillamente divertirsi a battere in volata le potenti Bayard-Clémant di Monsieur Fournier e di Monsieur Tellier, rappresentanti di quella sorella latina così arrogante ( ma quel giorno non bisognava parlarne ) nei confronti del nostro Paese.
Per ogni evenienza c'erano poi i dodici posti di soccorso della Croce Rossa, ma medici e crocerossine, in quell'assolata domenica di maggio, non si prodigarono 'che per offrire dei bicchieri di acqua gelata con alchermes alle signore e dei sorsi di cognac ai commissari' non bastando il 'ristorante appositamente attrezzato' a coprire il fabbisogno di 'rinfreschi e bibite di ogni natura'.
Per il pubblico c'erano poi da costruire le installazioni in legno, preferibilmente in stile moresco come è di uso in quei tempi, i chilometri di barriere, i duecento metri di tribune 'inghirlandate di foglie e frutti di limoni e di aranci' e i cavalcavia nei posti di passaggio più affollati, ornati con gran pavese.
Per i corridori c'erano i premi da preparare, fra cui fa spicco la bella Targa di bronzo dorato con Monte Pellegrino che si specchia, ad opera degli abili colpi di bulino dello scultore René Lalique, nel golfo di Palermo.
Per la storia, bisogna preparare le pubblicazioni sportive affidate a grafici di sommo valore ed artisti come Cambellotti e Dudovich.
Tutto in uno stile elegante e festoso come si conviene a un tempo su cui incombe 'il compito eletto di nobilitare col battesimo della bellezza tutte le sue conquiste'.
Padrini di questo battesimo sono gli audaci del bel mondo, i pionieri della Targa Florio, gli spettatori in panama bianco, per l'occasione con il cronometro all'occhiello, in luogo della consueta gardenia e le affascinanti spettatrici col candido parasole e le piume di struzzo sul cappello.
Un'eleganza degna del 'Derby' di Londra.
E mi si perdoni il raffronto, con una famosa manifestazione ippica, per una gara in cui il vinto dev'essere proprio il cavallo.
Ma il fatto è che questo nobile animale al tramonto, all'inizio del ventesimo secolo è ancora così pieno di vitalità che è impossibile ignorarlo o sopprimerlo.
Intanto quel Cambellotti che ce lo aveva mostrato morto sulla copertina di 'Rapiditas' nel 1906, in quella dell'anno dopo ne effigia tutto un branco, annitrente di rabbia verso una macchina che passa.
E i cavalli circondano, come ombre del passato, e quasi sommergono l'aurea vetturetta sulla Targa del 1908 ( la targa consegnata in premio al vincitore ).
Ma le stesse macchine si misurano ancora a cavalli; quella privata di don Vincenzo ne ha settanta, mentre il signor Ducrot nella sua industria di Palermo ne utilizza duecentocinquanta per le sue cento macchine e i bersaglieri chiamati in aiuto sul luogo della corsa, giungono sui loro 'cavalli d'acciaio'.
Spuntano fuori da tutte le parti questi cavalli.
Li cacci via e ti si avventano addosso, sotto forma di cavalli vapore, ti entrano in cinquanta, in settanta dentro i cilindri della tua macchina e ne escono trasformati in potenza come da quello di un prestigiatore.
Certo era già una bella vittoria, l'aver rinunciato definitivamente alle quattro gambe artificiali dell'automobile che David Gordon proponeva qualche decennio prima. Ma rimanevano quelle carrozzerie da passeggio a cui manca soltanto la doppia coppia di quadrupedi dinanzi per farne un sontuoso tiro a quattro, e i corridori che si presentano al 'pesage' ( le macchine si pesano prima della corsa ) con un abbigliamento incerto tra la divisa del fantino e la tuta del meccanico, balzano sul sedile con abilità da maneggio.
Tu li vedi, sui documenti fotografici dell'epoca, quasi caracollanti su uno strano destriero.
Vedi Graziani che sembra frustare la groppa metallica della sua 'Itala' e il meccanico di Cagno che al traguardo fa il gesto del cavaliere che tira le briglie.
E' un residuo ancestrale che opera tuttora nel fondo degli uomini moderni?
Ma ritorniamo al nostro circuito.
Il cavaliere Vincenzo Florio vi si trova già da qualche ora, quando l'alba comincia a indorare le bandiere di tre nazioni che garriscono sui pennoni delle tribune.
Il duca Airoldi e il conte di Mazzarino arrivano sulle loro 'settanta cavalli' mentre i contadini dei paesi vicini sopraggiungono più lentamente sui carretti variopinti, tirati dalle loro giumente, appena in tempo prima che la strada sia 'consegnata' e alla stazione provvisoria 'stabilita per l'occasione al punto di partenza della corsa' impiegati, commercianti, professionisti e operai della città sono incessantemente vomitati dai treni speciali.
Circa ventimila se ne riunirono sul posto tra nobili, borghesi e plebei.
Al sorgere del sole la campagna di Bonfornello 'offriva un magnifico colpo d'occhio' tanto che il raccolto del grano andò perduto per diversi ettari attorno alle tribune.
Alle 5.30 le dieci vetture sono in linea.
Alle 6.00 lo starter G. M. Marley, cronometrizzatore dell'ACI, dà il via con il consueto stile al primo partente, Lancia su Fiat.
'Essendo stato il circuito sottoposto alla vigilia ad un processo di
vestrumitaggio con Fix la partenza dei corridori non solleva troppa polvere'.
Ma sia detto francamente, il vestrumitaggio con Fix non ci persuade molto. Sulle fotografie un po' sbiadite biancheggia, dietro ogni macchina, una densa scia di polvere e nonostante i dieci muniti d'intervallo, siamo sicuri che la barba nera di Monsieur Le Blon, secondo alla partenza, dovette ben presto ingrigire, non certo per la paura in un uomo di quella tempra.
Nella nube dei coniugi Le Blon s'immergeva Cagno, poi seguito da Achille Fournier. Bablot è il quinto a partire e il sesto Pope.
L'inglese 'parte secondo la tradizione con un grosso sigaro tra le labbra'.
Pure, ai rifornimenti, è proibito fumare, sarà partito col sigaro spento? Forse la Storia non chiarirà mai questo particolare, ma la Fortuna punì il suo esibizionismo. Pope 'ebbe un tubo spezzato perciò rimase in panne'.
Intanto incominciano ad arrivare i primi dispacci.
Nel circuito vi sono otto stazioni telegrafiche allacciate con un ufficio telegrafico provvisorio fornito di quattro macchine Morse.
Una bella rete per gli aficionados del totalizzatore e per i cronometristi.
Il sole comincia a scottare e un ansioso calore s'impadronisce della folla presente.
Non sono ancora passate tre ore, quando a un tratto 'un colpo di cannone da Campofelice annuncia l'entrata' del primo nel rettifilo del traguardo. Era tempo che all'opera della fanteria e dei bersaglieri si unisse quella dell'artiglieria.
'Subito dopo una tromba squilla' e Lancia passa come un razzo, poi Cagno 'che ha guadagnato sette metri'. De Caters 'passa a capo scoperto avendo perduto il suo berretto'.
Ma 'quando il cannone tonò novamente' fu Cagno a passare per primo fra le altissime acclamazioni 'avendo oltrepassato Lancia, che si credeva sempre in testa, facendo mostra di superbo sforzo' e non si avvide del sorpasso, forse a causa della densa nebbia che ormai avvolgeva, nonostante il vestrumitaggio, cose e persone.
Il passaggio di Le Blon è applauditissimo, soprattutto per 'il coraggio di cui ha dato prova e per la sua vettura ancora in perfetta tenuta' ( si sottintende forse, nonostante l'opera di meccanico apprestata dalla moglie?).
Poi passa De Caters 'sempre a capo scoperto', evidentemente non ha avuto il tempo di fermarsi a raccattare il cappello. Intanto 'si apprende che Achille Fournier è stato arrestato per avere investito un paracarri'. Il provvedimento sembra eccessivo, ma con tanta forza pubblica, che volete, bisogna pur fare qualcosa.
Pope ha avuto un indugio 'per mancanza di benzina' o forse perché non trova i fiammiferi? Questo inglese con la faccia grassa e molle, unico corridore privo di baffi, non ci piace molto.
Rigal il 'favorito delle scommesse' e Bablot 'il grande favorito francese' hanno commesso, vedi fatalità, la medesima distrazione: 'per un deplorevole equivoco, versarono acqua invece di essenza nei loro serbatoi'.
Sono le 3,52' e 22", quando Cagno tocca il traguardo e con un colpo di freno spacca il cardano ( un episodio bello come il cuore del messaggero di Maratona che si spezza alla meta ).
'L'eccellente conduttore è portato in trionfo' però poteva andarci più adagio a frenare.
Graziani è secondo. Bablot è terzo e quarto Rigal nonostante l'acqua bevuta. De Caters arriva quinto, ma il suo copricapo è per sempre perduto. L'intrepida signora Le Blon che è riuscita financo a mantenere immacolato il suo serico foulard, in un percorso dove di solito 'i meccanici vomitano' 'si mostra sorridente e non molto stanca', mentre il marito si spolvera la barba che, sbattendo al vento della corsa sul suo petto, gli ha forse impedito un piazzamento migliore. Comunque gli sposi sono arrivati sesti.
Così si compiva cinquant'anni fa la prima 'Targa Florio', un esempio mirabile di 'organizzazione perfetta, di spirito agonistico, di interesse sportivo'.
Parli per noi la media tenuta di km 46,800 su 446,469 di percorso e la esiguità degli incidenti. Certo, per Bablot e Rigal, la benzina non è acqua, ma un cappello perduto , per De Caters, non è gran danno, anche se nel 1906 è vergogna camminare per le strade a capo scoperto, e il tubo rotto di Pope ci sembra proprio una punizione divina per l'eccessiva 'nonchalance' inglese.
Ma se i risultati tecnici di quella prima prova non furono molto notevoli, se quella corsa dell'ormai lontano 1906, fu piuttosto un torneo per divertire l'aristocrazia palermitana che una seria competizione sportiva, il fatto stesso che grandi piloti e grandi case vi partecipassero, anche senza troppo impegnarsi, come a un giro di prova, era già molto significativo.
Non più tardi di un anno, il nome di Florio doveva richiamare per la seconda volta l'attenzione dell'industria automobilistica mondiale, e con ben altri risultati, su quel roccioso lembo di terra siciliana, dove si disputava la Targa.
La corsa, si scrive nel 1907, è 'volta a fini eminentemente pratici'. Essa 'è destinata a fornire il criterio intorno alla consistenza, al valore dell'odierna industria automobilistica'.
Si fa strada nella mente degli organizzatori il concetto che una corsa non è soltanto un divertimento, ma anche un utile collaudo di macchine.
'Quello che sembrava un gioco o tutt'al più uno spettacolo di proporzioni più grandiose del consueto, ci appare come uno dei più complicati e dei più gravi affari a cui ci si possa accingere'.
E fu in quel secondo anno che si posero le basi di una tradizionale gara che rimane ancora una delle più importanti del genere, ed è divenuta, dal 1955, la prova decisiva per il 'campionato del mondo'.
Come sempre, si comincia per gioco e si finisce col fare sul serio...".
Il 1956 coincise con il cinquantenario della Targa Florio.
L'anniversario venne celebrato dalla rivista "Civiltà delle Macchine" - edita a Roma da Finmeccanica - nel numero pubblicato per il bimestre maggio-giugno grazie ad un reportage del giornalista Beppe Fazio.
La narrazione di Fazio citò allora parecchi stralci dell'anonimo racconto della prima edizione della Targa Florio pubblicato all'epoca sul primo numero della rivista "Rapiditas", organo ufficiale di informazione della corsa madonìta dal 1906 sino al 1930.
La prima edizione della Targa prese il via all'alba della domenica del 6 maggio di 109 anni fa sul "Grande Circuito delle Madonie", con appena dieci vetture alla partenza: uno sciopero improvviso dei lavoratori marittimi rese impossibile lo sbarco in Sicilia di molti altri equipaggi.
Base logistica della manifestazione fu il Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese e, come è noto, il settore delle Tribune fu posto fra Campofelice e Bonfornello, a due passi dalle allora semisconosciute rovine del sito archeologico di Himera.
L'adesione del pubblico fu massiccia, in linea con quanto sarebbe accaduto nei decenni in cui la Targa Florio fu prova valida per il Campionato mondiale Marche: i primi due treni con 30 vagoni partirono da Palermo alle 3 ed alle 3.30 della notte, e fecero la spola a pieno carico dalla Stazione Centrale sino a Bonfornello per almeno tre ore.
Il racconto di Beppe Fazio - che "Civiltà delle Macchine" corredò con alcune fotografie delle vetture in gara e le note illustrazioni di Marcello Dudovich, Duilio Cambellotti e Aleardo Terzi - ricostruisce l'atmosfera di quella prima pioneristica Targa Florio, a metà strada fra evento sportivo ed appuntamento mondano.
 |
| Mondanità sulle Tribune poste fra Campofelice e Bonfornello. Quest'opera e quella che segue portano la firma del disegnatore triestino Marcello Dudovich |
Il dato agonistico della corsa passa in secondo piano rispetto al rilievo mostrato dall'accurata organizzazione della manifestazione da parte di un giovanissimo Vincenzo Florio.
L'inventore della Targa nel 1906 aveva appena 25 anni, ma dimostrava già quelle doti di intraprendenza e di organizzazione delle quali si è persa traccia da parecchi decenni in Sicilia.
Non è un caso che ancora ai nostri giorni l'unico evento siciliano conosciuto ancora fra molti appassionati sparsi nel mondo sia ancora, sempre ( e soltanto, purtroppo ) la Targa Florio.
"All'appello di Vincenzo Florio - scrisse Beppe Fazio - ben ventidue 'barriti crepitanti' risposero; anche se poi furono soltanto dieci le macchine che arrivarono in porto a Palermo, ospiti delle navi della flotta Florio, messe gratuitamente a disposizione ( un inopinato sciopero di portuali ne fermava dodici a Genova ).
Dieci macchine delle migliori case italiane e straniere, montate dai migliori assi del volante, ognuno col suo meccanico e, particolare gentile, accanto a un asso francese, una dama, Madame Le Blon, anche essa in veste di meccanico, anche le protegge il viso un femmineo bianco foulard di seta, che fa contrasto con la quadrata barba nera del marito.
Una nota gentile, che darà il 'la' alle targhe future, le quali saranno, non passerà un anno, le manifestazioni mondane preferite dalle signore; e si vedrà allora un comitato femminile d'onore composto dai più bei nomi dell'aristocrazia europea: la contessa d'Orsay, la principessa di Paternò, la Pignatelli, la principessa di Trabia, la Morosini, la marchesa di Soragna e infine, bella tra le belle, donna Franca Florio ( ai vecchi palermitani si incrina ancora la voce quando la nominano ).
Ma quest'anno ancora le signore sono un po' restie ad emergere, come divinità scese in terra dall'Olimpo, dalle nubi dorate, sollevate dalle macchine in corsa.
La Le Blon è un'altra cosa, è un esempio di dedizione coniugale, più che di spirito sportivo, e in corsa, seduta sulla poltroncina della sua Hotchkiss, avvolto ormai strettamente il viso nel foulard, come in un sudario, fa pensare, più che a un meccanico, alla moglie indiana che segue lo sposo oltre la vita.
Ma quel primo anno la corsa è un'avventura di audaci, è un salto nel buio e, pur se 'ciascun uomo moderno vive dieci vite', come scriveva l'entusiasta cronista del 1906, bisogna cercare di portarle a termine in certo qual modo tutte e dieci, e chi ci garantisce che quei 'titani sconosciuti' non saltino le stecconate?
Ma Vincenzo Florio, questo giovane gentleman di venticinque anni 'animato dalla più generosa e ardente passione per lo sport' ha pensato a tutto: con la sua capacità di divinazione ha capito che il circuito delle Madonie, diverrà col tempo una corsa ben più importante di quel primo tentativo di dieci vetture.
 |
| La morte di un cavallo ed il trionfo dei cavalli vapore sul tracciato della Targa Florio. Anche quest'opera porta la firma del romano Duilio Cambellotti |
L'automobilismo sta diventando un fenomeno di massa, in quei primi anni del Novecento e il mondo industriale, in quel momento, guarda quel che succede nella lontana Sicilia; e anche quella 'lieta festa del progresso' non del tutto riuscita, è un nuovo passo verso l'ingresso definitivo dell'automobile nella vita sociale.
Bisogna stare molto attenti per evitare critiche e incidenti.
La eco delle 'frasi mordaci' contro le gare automobilistiche non era ancora spenta, circolavano ancora 'macchiette eccitanti all'odio che tendevano a far passare gli appassionati della nuova macchina divoratrice dello spazio come maniaci macabri'.
A queste bisognavano contrapporre una organizzazione di ferro.
Si pensi alla forza pubblica che si riuscì a concentrare sul posto.
Contro i dieci 'bolidi scatenati' si schieravano in pieno assetto di guerra 'duecento carabinieri, un gran numero di agebnti di polizia, tremila uomini di fanteria di linea schierati lungo il percorso, una compagnia di bersaglieri ciclisti incaricata del servizio di staffetta'.
L'ironia è facile, ma allora, grazie a quei brevi militari, 'il servizio d'ordine funzionò a meraviglia' e non si verificarono danni agli spettatori.
 |
| L'arrivo di Victor Rigal su una Itala. Nel suo reportage, Beppe Fazio racconta che l'allestimento delle tribune fra Campofelice e Bonfornello fu realizzato grazie al taglio di alcuni campi di grano |
Del resto il pericolo di una guerra era ben lontano e i bersaglieri di Lamarmora nell'attesa, potevano tranquillamente divertirsi a battere in volata le potenti Bayard-Clémant di Monsieur Fournier e di Monsieur Tellier, rappresentanti di quella sorella latina così arrogante ( ma quel giorno non bisognava parlarne ) nei confronti del nostro Paese.
Per ogni evenienza c'erano poi i dodici posti di soccorso della Croce Rossa, ma medici e crocerossine, in quell'assolata domenica di maggio, non si prodigarono 'che per offrire dei bicchieri di acqua gelata con alchermes alle signore e dei sorsi di cognac ai commissari' non bastando il 'ristorante appositamente attrezzato' a coprire il fabbisogno di 'rinfreschi e bibite di ogni natura'.
Per il pubblico c'erano poi da costruire le installazioni in legno, preferibilmente in stile moresco come è di uso in quei tempi, i chilometri di barriere, i duecento metri di tribune 'inghirlandate di foglie e frutti di limoni e di aranci' e i cavalcavia nei posti di passaggio più affollati, ornati con gran pavese.
Per i corridori c'erano i premi da preparare, fra cui fa spicco la bella Targa di bronzo dorato con Monte Pellegrino che si specchia, ad opera degli abili colpi di bulino dello scultore René Lalique, nel golfo di Palermo.
Per la storia, bisogna preparare le pubblicazioni sportive affidate a grafici di sommo valore ed artisti come Cambellotti e Dudovich.
Tutto in uno stile elegante e festoso come si conviene a un tempo su cui incombe 'il compito eletto di nobilitare col battesimo della bellezza tutte le sue conquiste'.
 |
| Vincenzo Lancia alla partenza al volante di una Fiat |
Padrini di questo battesimo sono gli audaci del bel mondo, i pionieri della Targa Florio, gli spettatori in panama bianco, per l'occasione con il cronometro all'occhiello, in luogo della consueta gardenia e le affascinanti spettatrici col candido parasole e le piume di struzzo sul cappello.
Un'eleganza degna del 'Derby' di Londra.
E mi si perdoni il raffronto, con una famosa manifestazione ippica, per una gara in cui il vinto dev'essere proprio il cavallo.
Ma il fatto è che questo nobile animale al tramonto, all'inizio del ventesimo secolo è ancora così pieno di vitalità che è impossibile ignorarlo o sopprimerlo.
Intanto quel Cambellotti che ce lo aveva mostrato morto sulla copertina di 'Rapiditas' nel 1906, in quella dell'anno dopo ne effigia tutto un branco, annitrente di rabbia verso una macchina che passa.
E i cavalli circondano, come ombre del passato, e quasi sommergono l'aurea vetturetta sulla Targa del 1908 ( la targa consegnata in premio al vincitore ).
Ma le stesse macchine si misurano ancora a cavalli; quella privata di don Vincenzo ne ha settanta, mentre il signor Ducrot nella sua industria di Palermo ne utilizza duecentocinquanta per le sue cento macchine e i bersaglieri chiamati in aiuto sul luogo della corsa, giungono sui loro 'cavalli d'acciaio'.
Spuntano fuori da tutte le parti questi cavalli.
Li cacci via e ti si avventano addosso, sotto forma di cavalli vapore, ti entrano in cinquanta, in settanta dentro i cilindri della tua macchina e ne escono trasformati in potenza come da quello di un prestigiatore.
 |
| Un passaggio del vincitore della Targa Florio del 1906, il piemontese Alessandro Cagno alla guida di una Itala |
Certo era già una bella vittoria, l'aver rinunciato definitivamente alle quattro gambe artificiali dell'automobile che David Gordon proponeva qualche decennio prima. Ma rimanevano quelle carrozzerie da passeggio a cui manca soltanto la doppia coppia di quadrupedi dinanzi per farne un sontuoso tiro a quattro, e i corridori che si presentano al 'pesage' ( le macchine si pesano prima della corsa ) con un abbigliamento incerto tra la divisa del fantino e la tuta del meccanico, balzano sul sedile con abilità da maneggio.
Tu li vedi, sui documenti fotografici dell'epoca, quasi caracollanti su uno strano destriero.
Vedi Graziani che sembra frustare la groppa metallica della sua 'Itala' e il meccanico di Cagno che al traguardo fa il gesto del cavaliere che tira le briglie.
E' un residuo ancestrale che opera tuttora nel fondo degli uomini moderni?
Ma ritorniamo al nostro circuito.
Il cavaliere Vincenzo Florio vi si trova già da qualche ora, quando l'alba comincia a indorare le bandiere di tre nazioni che garriscono sui pennoni delle tribune.
Il duca Airoldi e il conte di Mazzarino arrivano sulle loro 'settanta cavalli' mentre i contadini dei paesi vicini sopraggiungono più lentamente sui carretti variopinti, tirati dalle loro giumente, appena in tempo prima che la strada sia 'consegnata' e alla stazione provvisoria 'stabilita per l'occasione al punto di partenza della corsa' impiegati, commercianti, professionisti e operai della città sono incessantemente vomitati dai treni speciali.
Circa ventimila se ne riunirono sul posto tra nobili, borghesi e plebei.
Al sorgere del sole la campagna di Bonfornello 'offriva un magnifico colpo d'occhio' tanto che il raccolto del grano andò perduto per diversi ettari attorno alle tribune.
Alle 5.30 le dieci vetture sono in linea.
Alle 6.00 lo starter G. M. Marley, cronometrizzatore dell'ACI, dà il via con il consueto stile al primo partente, Lancia su Fiat.
'Essendo stato il circuito sottoposto alla vigilia ad un processo di
vestrumitaggio con Fix la partenza dei corridori non solleva troppa polvere'.
Ma sia detto francamente, il vestrumitaggio con Fix non ci persuade molto. Sulle fotografie un po' sbiadite biancheggia, dietro ogni macchina, una densa scia di polvere e nonostante i dieci muniti d'intervallo, siamo sicuri che la barba nera di Monsieur Le Blon, secondo alla partenza, dovette ben presto ingrigire, non certo per la paura in un uomo di quella tempra.
Nella nube dei coniugi Le Blon s'immergeva Cagno, poi seguito da Achille Fournier. Bablot è il quinto a partire e il sesto Pope.
L'inglese 'parte secondo la tradizione con un grosso sigaro tra le labbra'.
Pure, ai rifornimenti, è proibito fumare, sarà partito col sigaro spento? Forse la Storia non chiarirà mai questo particolare, ma la Fortuna punì il suo esibizionismo. Pope 'ebbe un tubo spezzato perciò rimase in panne'.
Intanto incominciano ad arrivare i primi dispacci.
Nel circuito vi sono otto stazioni telegrafiche allacciate con un ufficio telegrafico provvisorio fornito di quattro macchine Morse.
Una bella rete per gli aficionados del totalizzatore e per i cronometristi.
Il sole comincia a scottare e un ansioso calore s'impadronisce della folla presente.
Non sono ancora passate tre ore, quando a un tratto 'un colpo di cannone da Campofelice annuncia l'entrata' del primo nel rettifilo del traguardo. Era tempo che all'opera della fanteria e dei bersaglieri si unisse quella dell'artiglieria.
'Subito dopo una tromba squilla' e Lancia passa come un razzo, poi Cagno 'che ha guadagnato sette metri'. De Caters 'passa a capo scoperto avendo perduto il suo berretto'.
Ma 'quando il cannone tonò novamente' fu Cagno a passare per primo fra le altissime acclamazioni 'avendo oltrepassato Lancia, che si credeva sempre in testa, facendo mostra di superbo sforzo' e non si avvide del sorpasso, forse a causa della densa nebbia che ormai avvolgeva, nonostante il vestrumitaggio, cose e persone.
Il passaggio di Le Blon è applauditissimo, soprattutto per 'il coraggio di cui ha dato prova e per la sua vettura ancora in perfetta tenuta' ( si sottintende forse, nonostante l'opera di meccanico apprestata dalla moglie?).
Poi passa De Caters 'sempre a capo scoperto', evidentemente non ha avuto il tempo di fermarsi a raccattare il cappello. Intanto 'si apprende che Achille Fournier è stato arrestato per avere investito un paracarri'. Il provvedimento sembra eccessivo, ma con tanta forza pubblica, che volete, bisogna pur fare qualcosa.
Pope ha avuto un indugio 'per mancanza di benzina' o forse perché non trova i fiammiferi? Questo inglese con la faccia grassa e molle, unico corridore privo di baffi, non ci piace molto.
Rigal il 'favorito delle scommesse' e Bablot 'il grande favorito francese' hanno commesso, vedi fatalità, la medesima distrazione: 'per un deplorevole equivoco, versarono acqua invece di essenza nei loro serbatoi'.
Sono le 3,52' e 22", quando Cagno tocca il traguardo e con un colpo di freno spacca il cardano ( un episodio bello come il cuore del messaggero di Maratona che si spezza alla meta ).
'L'eccellente conduttore è portato in trionfo' però poteva andarci più adagio a frenare.
Graziani è secondo. Bablot è terzo e quarto Rigal nonostante l'acqua bevuta. De Caters arriva quinto, ma il suo copricapo è per sempre perduto. L'intrepida signora Le Blon che è riuscita financo a mantenere immacolato il suo serico foulard, in un percorso dove di solito 'i meccanici vomitano' 'si mostra sorridente e non molto stanca', mentre il marito si spolvera la barba che, sbattendo al vento della corsa sul suo petto, gli ha forse impedito un piazzamento migliore. Comunque gli sposi sono arrivati sesti.
Così si compiva cinquant'anni fa la prima 'Targa Florio', un esempio mirabile di 'organizzazione perfetta, di spirito agonistico, di interesse sportivo'.
Parli per noi la media tenuta di km 46,800 su 446,469 di percorso e la esiguità degli incidenti. Certo, per Bablot e Rigal, la benzina non è acqua, ma un cappello perduto , per De Caters, non è gran danno, anche se nel 1906 è vergogna camminare per le strade a capo scoperto, e il tubo rotto di Pope ci sembra proprio una punizione divina per l'eccessiva 'nonchalance' inglese.
Ma se i risultati tecnici di quella prima prova non furono molto notevoli, se quella corsa dell'ormai lontano 1906, fu piuttosto un torneo per divertire l'aristocrazia palermitana che una seria competizione sportiva, il fatto stesso che grandi piloti e grandi case vi partecipassero, anche senza troppo impegnarsi, come a un giro di prova, era già molto significativo.
Non più tardi di un anno, il nome di Florio doveva richiamare per la seconda volta l'attenzione dell'industria automobilistica mondiale, e con ben altri risultati, su quel roccioso lembo di terra siciliana, dove si disputava la Targa.
La corsa, si scrive nel 1907, è 'volta a fini eminentemente pratici'. Essa 'è destinata a fornire il criterio intorno alla consistenza, al valore dell'odierna industria automobilistica'.
Si fa strada nella mente degli organizzatori il concetto che una corsa non è soltanto un divertimento, ma anche un utile collaudo di macchine.
'Quello che sembrava un gioco o tutt'al più uno spettacolo di proporzioni più grandiose del consueto, ci appare come uno dei più complicati e dei più gravi affari a cui ci si possa accingere'.
E fu in quel secondo anno che si posero le basi di una tradizionale gara che rimane ancora una delle più importanti del genere, ed è divenuta, dal 1955, la prova decisiva per il 'campionato del mondo'.
Come sempre, si comincia per gioco e si finisce col fare sul serio...".